Le Stelle nr. 60 Marzo 2008

-
Supernovae Una minaccia per la Terra?30
Supernovae Una minaccia per la Terra?
Mark A. Garlick
Una supernova vicina può offrire uno spettacolo pirotecnico inusitato, ma potrebbe anche devastare l’atmosfera del nostro pianeta. A quale distanza dovremmo considerarla una concreta minaccia?
Nel corso della sua storia, lunga 4,6 miliardi di anni, il nostro pianeta ha più volte subito subitanee estinzioni di flora e fauna. I resti fossili ci dicono che si verificarono cinque “estinzioni di massa” davvero catastrofiche, durante le quali gran parte delle specie viventi fu spazzata via in un tempo brevissimo su scala geologica. La fine dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, è il più famoso di questi sconvolgimenti, sebbene non il più devastante in assoluto nella storia della Terra. Tra le possibili cause di questi rari eventi, sono state annoverate i cambiamenti climatici, l’attività solare, il vulcanesimo e gli impatti asteroidali. Ma gli astronomi hanno chiamato in causa come sospetti killer anche le supernovae. Per un tempo piuttosto breve, una supernova (l’esplosione catastrofica che pone fine alla vita di una stella) può superare in luminosità un’intera galassia. Immaginiamo con raccapriccio cosa succederebbe se la luce delle centinaia di miliardi di stelle che fanno parte della galassia M31 in Andromeda scaturisse tutta da un luogo posto a pochi anni luce di distanza da noi. Non è difficile capire che una supernova vicina potrebbe tragicamente segnare il destino della nostra biosfera. Tags:ASTROFISICA






-
Migrazioni planetarie37
Migrazioni planetarie
Mark Littmann
Nel Sistema Solare dei primordi, lievi perturbazioni gravitazionali esercitate da miliardi di oggetti ghiacciati produssero effetti dirompenti sulle orbite dei pianeti giganti.
Al di là del confine tracciato dai suoi otto pianeti ufficialmente riconosciuti come tali, il nostro Sistema Solare è costituito da un piccolo mondo ormai declassato, chiamato Plutone, e da almeno un migliaio di oggetti con diametro superiore a 100 km: planetesimi, oppure pianeti nani. In mezzo ad essi, orbitano miliardi di blocchi di ghiaccio mischiato a rocce, che a volte si possono rendere visibili ai nostri occhi come spettacolari comete. Questa miriade di oggetti occupa uno spazio molto più esteso di quello ove orbitano gli otto pianeti, anche se la loro massa totale assomma a solo un decimo della massa della Terra, grosso modo la massa di Marte. Si immagini di prendere una mazza e di frantumare un mondo di ghiaccio e di rocce in alcuni frammenti delle dimensioni di Plutone e in miliardi di frammenti minori. Poi si immagini di disperderli in un’area che sia estesa il doppio della regione occupata da tutti i pianeti, da Mercurio a Nettuno. Questa è la situazione in cui si trova la Fascia di Kuiper. Sembrerebbe dunque solo un deposito di rottami, ma il valore della Fascia è quello di un pezzo d’antiquariato. Ricostruendo le modalità della sua formazione, essa può infatti raccontarci una parte importante della storia del Sistema Solare. Tags:SISTEMA SOLARE





-
Comete nell’antichità44
Comete nell’antichità
John Steele
In Mesopotamia e in Cina la loro comparsa veniva interpretata in chiave astrologica. Aristotele le considerava esalazioni di gas terrestri e tale opinione resse per quasi due millenni. La loro natura di oggetti celesti venne appurata solo quattro secoli fa, da Tycho Brahe.
Il 4 luglio 2005, la navicella Deep Impact della NASA scagliò un proiettile contro la superficie della cometa Tempel 1, che è così entrata nella storia come la prima cometa a subire un intervento dell’uomo. Per migliaia di anni, le comete sono state fonte di terrore, hanno fatto presagire la caduta di regnanti e ogni sorta di disastri naturali, ma mai prima d’ora gli uomini erano stati in grado di modificare le loro orbite, oppure la loro topografia e il loro aspetto. Nei secoli scorsi, azioni di questo tipo sarebbero apparse assolutamente fantasiose e incredibili. Le comete venivano viste come segni degli dei, palle infuocate comparse in cielo per criticare le azioni degli uomini o ammonirli: perciò, se anche si fosse potuto viaggiare in cielo, come sarebbe stato possibile modificare il corso di un astro guidato dagli dei o atterrare su una palla di fuoco? Nell’antichità le comete erano viste solo come oggetti sovrannaturali e raramente si speculò sulla loro natura fisica. In Cina si diceva fossero frutto di squilibri tra lo Yin e lo Yang, mentre per Aristotele non erano eventi astronomici, ma fenomeni meteorologici confinati nel mondo sub-lunare. Fu soltanto con Edmond Halley, negli ultimi anni del XVII secolo, che si capì che alcune comete ritornavano periodicamente a far visita alla Terra poiché si muovevano su orbite fortemente ellittiche, e che i loro ritorni potevano essere predetti con precisione. Tuttavia, per molte persone le comete ancora ai nostri giorni suscitano meraviglia e paura. Tags:







-
Sulle orme di Caroline Herschel52
Sulle orme di Caroline Herschel
Michael Hoskin
Caroline Herschel (1750-1848) è stata la prima grande signora dell’astronomia. Anche se divenne famosa ai suoi tempi per la scoperta di ben 8 comete, non si deve dimenticare che iniziò i suoi studi come osservatrice del cielo profondo. Fra il 1783 e il 1787 scoprì due nuove galassie e 12 ammassi stellari; di questi oggetti, quattro erano stati già osservati in precedenza, ma non erano stati inseriti ufficialmente in un catalogo, oppure vi erano stati riportati con posizioni errate. Le sue prime scoperte stimolarono il fratello William a “scandagliare il cielo in cerca di nebulose e ammassi di stelle”, iniziando così quell’attività che avrebbe così tanto giovato all’astronomia moderna. La carriera di osservatrice di Caroline iniziò nell’autunno del 1782, quando il fratello accettò l’invito di Re Giorgio III di diventare astronomo presso la corte del Castello di Windsor. William, che era scapolo, portò con sé la sorella affinché si prendesse cura della casa, ma le fornì anche un piccolo rifrattore, invitandola a scandagliare il cielo annotando tutto ciò che poteva essere interessante. Molto presto Caroline si imbatté in quegli oggetti di Messier che il fratello non aveva ancora osservato e il 26 febbraio 1783 scoprì due nebulose. Entrambi si resero conto immediatamente che si trattava di due nuove scoperte, e William ne dedusse che le nebulose dovevano essere così numerose che anche un principiante con un piccolo telescopio (poco più che un giocattolo) era in grado di scoprirne. Tags:


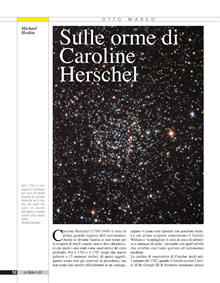
-
Spettacolo Geminidi56
Spettacolo Geminidi
Antonio Finazzi
Cinque fotocamere digitali per catturare lo sciame più spettacolare del cielo d’inverno. Quest’anno le meteore sono state numerose e sono comparse in un cielo impreziosito da una cometa.
L’avvento della fotografia digitale ha portato nuovi stimoli in astrofotografia. Lo scorso 14 dicembre era previsto che si verificasse il picco d’attività dello sciame meteorico delle Geminidi nelle prime ore serali, in una situazione decisamente favorevole, sia dal punto di vista dell’orario che da quello del disturbo lunare. Nell’occasione, per me lo stimolo è stato quello di collocare definitivamente a riposo le mie quattro macchine fotografiche reflex analogiche, antiche compagne di molte campagne osservative, e affidarmi per la prima volta solo a reflex digitali: in tutto ne abbiamo schierate cinque, tra cui le tre digitali modificate per astronomia dell’amico Michele Festa. Visto che la situazione meteo era abbastanza favorevole, abbiamo deciso di dedicare non una, ma due serate all’astrofotografia in alta montagna, a 1750 m di quota sul Monte Avaro, nelle Orobie bergamasche, incoraggiati anche dal fatto che lassù ci attende l’albergo rifugio Monte Avaro dove si può dormire, mangiare e dove il gestore è sempre disponibilissimo a fornire la corrente elettrica e a spegnere le luci di disturbo. Naturalmente, avevo pianificato tutto a tavolino. La prima serata, il giorno 13, è stata dedicata soprattutto alla fotografia della cometa 17P/Holmes con focali di media lunghezza, tra 200 e 300 mm; in contemporanea, due reflex digitali lavoravano con focali grandangolari, caso mai si fosse verificato un anticipo delle Geminidi. Tags:OSSERVAZIONI




-
Prospettive cosmiche62
Prospettive cosmiche
Phillip Kane
Come stabilire in modo semplice quali siano le effettive grandezze degli oggetti del profondo cielo.
Quando guardiamo nell’oculare di un telescopio, dentro il quale vengono inquadrati oggetti grandi e antichi, che si trovano a distanze inimmaginabili, vedere le cose per quello che realmente sono, ossia vedere con gli occhi della mente, è davvero una sfida formidabile. Nel tentativo di guardare alle cose nella loro giusta dimensione, io trovo che sia molto utile sforzarsi di visualizzare la scala delle grandezze che si vedono attraverso il telescopio. Il lettore mi segua in questi pochi semplici esempi. Per chi inizia potrebbe tornar comodo usare l’oculare per misurare le dimensioni fisiche degli oggetti del cielo profondo che si stanno osservando. Supponiamo che voi stiate guardando M13, il famoso ammasso globulare della costellazione di Ercole, e che esso occupi il 40% del campo di vista del vostro oculare. Quanti anni luce sarà estesa questa enorme “palla” di stelle? Per rispondere avrete bisogno di due distinte informazioni: la distanza di M13 e l’ampiezza angolare del campo di vista del vostro oculare. M13 si trova a 25 mila anni luce dalla Terra (con un’incertezza del 10%). Le distanze cosmiche sono difficili da misurare e vengono continuamente riviste, quindi vi converrà ricavarle caso per caso da qualche sito web autorevole e aggiornato. Quasi tutte le distanze che troverete in questo articolo vengono dal sito htpp://sedef.lpl.arizona.edu/messier/- objects.html, che contiene una quantità di buone informazioni riguardanti ciascuno degli oggetti di Charles Messier; c’è pure un link a fondo pagina che rimanda agli oggetti più significativi del cielo profondo che non rientrano nel catalogo del francese. Tags:OSSERVAZIONI



-
Le galassie dell’Eridano66
Le galassie dell’Eridano
Luigi Fontana
Abbiamo parlato il mese scorso di molte stelle interessanti dell’Eridano, e dei due principali oggetti del cielo profondo. Ma altre decine attendono la nostra attenzione, per essere osservati o fotografati. Sono praticamente tutte galassie, in quanto questa grande costellazione si trova tutta ad elevate latitudini galattiche. Solo l’angolo nord-orientale dell’Eridano, che confina con Orione, è vicino alla Via Lattea, ma in una zona in cui essa non è particolarmente densa. Quindi, puntando il telescopio verso il mitologico fiume, il nostro sguardo non è limitato dalle polveri presenti nel piano della nostra Galassia, e possiamo perciò raccogliere la luce che ha viaggiato indisturbata per milioni e milioni di anni, essendo stata emessa da miliardi e miliardi di stelle che compongono ogni galassia. Tags:



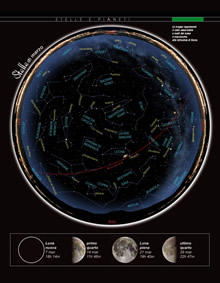

-
17P/Holmes: un’occasione perduta?72
17P/Holmes: un’occasione perduta?
Luciano Lai
L’astronomo Robert H. McNaught, scozzese di nascita, ma naturalizzato australiano, ha fatto centro un’altra volta, scoprendo la prima cometa del 2008, la C/2008 A1, come ben evidenzia la sua sigla provvisoria. Con questa sono ormai 27 le sue scoperte, a cui vanno aggiunte le 13 condivise con altri astronomi, per un totale di 40. Ovviamente, nel frattempo ha scoperto anche uno stuolo di pianetini che, se i conti sono aggiornati, dovrebbero essere intorno a 410. La sua fama resta peraltro legata all’indimenticabile C/2006 P1 (McNaught) che lo scorso anno ha infiammato i cieli del sud. McNaught impersonifica la classica figura del vecchio astronomo (sebbene ancora giovane, essendo nato nel 1956) che studia con passione e passa le notti incollato al telescopio: lavora a Siding Spring, nel deserto australiano, con un vecchio telescopio già in uso all’Osservatorio tedesco di Uppsala e riadattato alle esigenze delle camere CCD. Da lì esplora in continuazione il cielo meridionale nell’ambito di una ricerca su oggetti del Sistema Solare. La nuova scoperta di magnitudine 15 promette bene per il futuro e nel prossimo autunno dovrebbe raggiungere la magnitudine 7, anche se non in ottime condizioni per i nostri cieli. Tags:


-
L’invenzione del telescopio60
L’invenzione del telescopio
Gabriele Vanin
Chi ha inventato, e quando, il telescopio? Stranamente, ancor oggi, nonostante l’indagine accurata di molti studiosi, non siamo ancora in grado di dare una risposta definitiva a questa domanda. Nondimeno, la storia della sua ideazione è davvero straordinaria, e merita di essere raccontata proprio in occasione del 400-esimo anniversario della sua introduzione.
Sicuramente le lenti erano note fin dall’antichità. Sono stati trovati oggetti di vetro che sembrano lenti in vari siti, a Tiro (300 a.C.), a Pompei e nel Fayum (età imperiale). Aristofane (V sec. a.C.) e Teofrasto (III sec. a.C.) parlano dell’uso delle lenti per accendere un fuoco concentrando i raggi del Sole, e Plinio le cita come presidio utile per cauterizzare le ferite. Ma nessuna fonte antica ne parla come di un mezzo di aiuto alla visione. Fu l’astronomo arabo Alhazen (noto anche come al-Basri e al-Misri, rispettivamente “l’uomo di Bassora” e “l’egiziano”) il primo a utilizzare delle lenti convesse come lenti da ingrandimento, nell’XI secolo d.C. Alla fine del XIII secolo, a Venezia, cominciò l’applicazione delle lenti convesse come mezzi per correggere la presbiopia. In teoria, già a questo punto potrebbe essere avvenuta l’invenzione del cannocchiale: in verità esistono varie miniature medievali in cui si vedono persone osservare il cielo attraverso un lungo tubo, ma erano tubi vuoti, privi di lenti. In qualche caso si trattava di dispositivi utili a trovare con facilità il Polo Nord Celeste, ma in altri solo di congegni usati dagli astrologi per stupire e attirare l’attenzione del pubblico. Tags:








