Le Stelle nr. 73 Maggio 2009

-
Pamela: la ricerca di antimateria nello spazio34
Pamela: la ricerca di antimateria nello spazio
Marco Casolino, Piergiorgio Picozza
Perché nel nostro Universo prevale la materia sull’antimateria? A questa domanda che da anni tormenta i cosmologi e gli astrofisici di tutto il mondo prova a dare una risposta lo strumento PAMELA
L’Universo nasconde ancora molti segreti nonostante i nostri tentativi di comprenderne la natura. Gli enormi progressi scientifici del XX secolo hanno fornito un quadro molto dettagliato del mondo microscopico e macroscopico in cui viviamo, dalla fisica dell’infi- nitamente piccolo alla formazione dell’Universo nel suo complesso. La descrizione che è emersa ha evidenziato la nostra scarsa conoscenza della sua reale natura. Varie sono le questioni ancora aperte. Di cosa è composto realmente l’Universo? Solo il 4 per cento è costituito da particelle a noi note, protoni, elettroni e nuclei che costituiscono i pianeti, le stelle e le galassie. Un altro 23 per cento è costituito da materia “oscura”, distribuita in modo non uniforme nella nostra Galassia e nello spazio intergalattico e costituita da particelle a noi ignote, invisibili e al momento imperscrutabili ai nostri tentativi di identificazione. Il problema della cosiddetta “massa mancante” nell’Universo fu notato per la prima volta nel 1933 dall’astronomo svizzero Fritz Zwicky. Tags:COSMOLOGIA







-
In caverna per studiare il Sole42
In caverna per studiare il Sole
Giulio Manuzio
Alla scoperta dell’esperimento Borexino in corso presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso per la cattura e lo studio dei neutrini solari che ha come obiettivo la verifica del modello solare standard
Andare in una caverna per osservare le stelle è decisamente strano e poco usuale. Eppure è l’argomento di questo scritto che racconta come e perché un gruppo di ricercatori siano andati a studiare il cuore del Sole infilandosi nei laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) del Gran Sasso. La ricerca astrofisica, dal punto di vista strumentale, si può considerare divisa in due linee alternative; una di esse, quella classica e più nota, osserva e analizza le radiazioni elettromagnetiche che provengono dallo spazio con telescopi di vario genere (dai radiotelescopi fino ai telescopi per raggi X molli) che, però, in tutti i casi fanno uso di “lenti” che “focalizzano” le radiazioni elettromagnetiche in arrivo dal cosmo. Esiste tuttavia una seconda categoria di modi per raccogliere le informazioni che vengono dallo spazio: essa consiste nell’analizzare quelle particolari radiazioni per le quali non è più possibile costruire dei telescopi perché è impossibile realizzare, per esse, lenti o specchi. Tags:ASTROFISICA







-
I cataloghi delle sorgenti gamma di Agile e Fermi50
I cataloghi delle sorgenti gamma di Agile e Fermi
Patrizia Caraveo
A dieci anni dal catalogo della missione EGRET vengono pubblicati due nuovi cataloghi di sorgenti gamma, entrambi frutto di missioni che vedono largamente coinvolti gli scienziati del nostro paese.
L’ultimo catalogo delle sorgenti gamma di alta energia era stato pubblicato nel 1999 a coronamento della missione della NASA EGRET a bordo del Compton Gamma Ray Observatory. Nel febbraio 2009, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, le due missioni di astronomia gamma attualmente operative hanno presentato il loro primo catalogo di sorgenti: 40 per Agile, una piccola missione in orbita dall’aprile 2007, e 205 per Fermi, uno strumento di maggiori dimensioni lanciato nel giugno 2008 (v. Le Stelle n. 67, pp. 46-47). La capacità di rivelare le sorgenti celesti dipende dalle dimensioni dello strumento che utilizziamo e dal tempo che dedichiamo all’osservazione. Quanto maggiori sono le dimensioni dello strumento e il tempo dedicato, tanto maggiore sarà la capacità di studiare il cielo alla ricerca di sorgenti sempre più deboli. Il miglioramento però cresce non linearmente in funzione del tempo impiegato e delle dimensioni strumentali, ma piuttosto come la loro radice quadrata. Tags:ASTROFISICA





-
Seneca e le comete di Nerone56
Seneca e le comete di Nerone
Paolo Ulivi
Durante l’impero di Nerone (54-68 d.C.) apparvero in cielo addirittura tre comete luminose – e forse più – tutte ben visibili a occhio nudo e citate dalle cronache dell’epoca. Cronisti d’eccezione furono Seneca e Cheremone, i quali fornirono un’interpretazione assolutamente “moderna” di questi fenomeni
Il 9 agosto dell’anno 60 d.C. alcuni astronomi cinesi registrarono la comparsa nella costellazione del Perseo di una cometa la cui coda si estendeva per circa 2 gradi. Nelle settimane e nei mesi successivi la cometa si spostò verso la Vergine diventando sempre più vistosa e infine in dicembre, dopo ben 135 giorni di visibilità, scomparve. Dovette essere uno spettacolo grandioso, perché poche comete sono rimaste visibili a occhio nudo per un periodo così lungo. In quei tempi a capo dell’ancora giovane Impero Romano si trovava l’imperatore Nerone, e proprio dalla sua corte, e precisamente dal filosofo Lucio Anneo Seneca, ci giungono molte notizie su questo oggetto celeste. Seneca scrisse che la cometa “cominciò la propria apparizione a nord e passando attraverso l’ovest giunse nelle regioni meridionali dove scomparve”. Scrivendo più di cinquant’anni dopo, Publio Cornelio Tacito così descrisse la cometa nei suoi Annales: “… frattanto si vide splendere in cielo una cometa che, secondo le credenze popolari, dovrebbe annunciare un cambio di sovrano”. Tags:



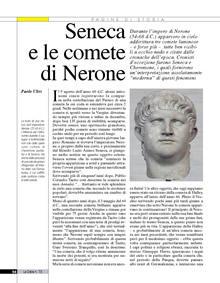
-
Un salto sul meridiano62
Un salto sul meridiano
E.C. Krupp
Tracciare una linea sulla terra per la scienza, il prestigio e la conoscenza
Ogni anno migliaia di turisti provenienti da longitudini lontane percorrono il cammino verso Greenwich, in Inghilterra, quasi come verso una meta di pellegrinaggio. Qui giunti, camminano sulla linea a longitudine 0° – il meridiano primo – e sistemano le gambe in modo da mettere un piede in ciascun emisfero, est e ovest, sul suolo del vecchio Osservatorio Reale. Questo meridiano è tracciato in ottone sul pavimento in pietra di fronte all’edificio che ospita il cerchio di transito acquistato e gestito da George Biddell Airy, settimo Astronomo Reale. Installato nel 1850, lo strumento di Airy ha stabilito, per la cartografia inglese, la linea fondamentale di riferimento che, tracciata lungo l’asse nord-sud, divide le longitudini tra est e ovest. Il re Carlo II Stuart aveva fondato l’Osservatorio Reale nel 1675. Egli voleva che fosse dedicato “all’identificazione della longitudine dei luoghi per perfezionare la navigazione e l’astronomia”. Fin dall’inizio il meridiano principale dell’Osservatorio era alla longitudine occupata dallo strumento del corrente Astronomo Reale. E i direttori dell’Osservatorio che si erano succeduti avevano via via spostato la linea verso est con l’aggiunta di nuovi strumenti. Una dislocazione conclusiva sopraggiunse nell’ottobre del 1884. Tags:



